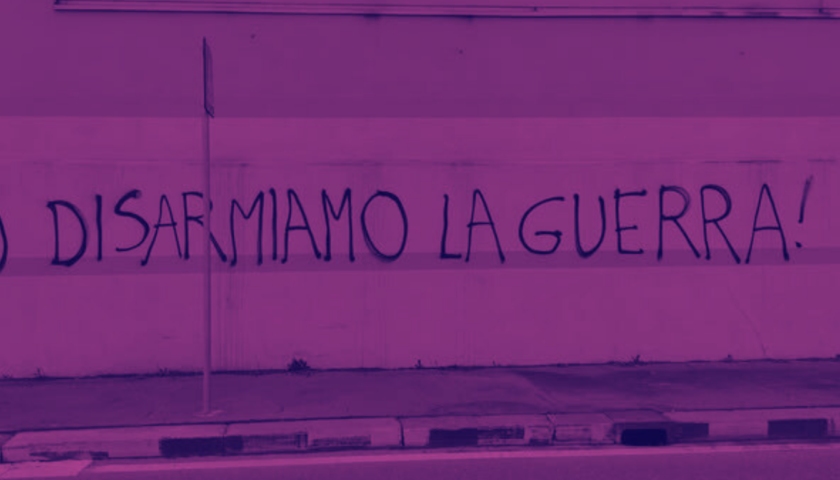All’attenzione dell’opinione pubblica e, in particolare, dei movimenti che si oppongono alla globalizzazione capitalistica, si è ultimamente piazzato il TTIP, un trattato di liberalizzazione commerciale tra le economie europee e quelle americane che modifica regolamentazioni e standard (le “barriere non tariffarie”) ed eliminare dazi e dogane tra i due lati dell’Atlantico. Le notizie rivelate da Green Peace, in sé e per sé, sono interessanti fino ad un certo punto, ma mostrano come come questo trattato contenga tutta una serie di risvolti estremamente deleteri per la vita quotidiana delle popolazioni coinvolte, che viene negoziato in segreto tra Commissione UE e Governo USA basandosi sulle esigenze dei grandi gruppi transnazionali che, in larga misura confliggono con gli interessi non solo della “gente comune” ma anche delle fasce medio/basse delle imprenditorie nazionali (il che spiega determinate reazioni negative da parte di fasce medio/alte della società).
All’attenzione dell’opinione pubblica e, in particolare, dei movimenti che si oppongono alla globalizzazione capitalistica, si è ultimamente piazzato il TTIP, un trattato di liberalizzazione commerciale tra le economie europee e quelle americane che modifica regolamentazioni e standard (le “barriere non tariffarie”) ed eliminare dazi e dogane tra i due lati dell’Atlantico. Le notizie rivelate da Green Peace, in sé e per sé, sono interessanti fino ad un certo punto, ma mostrano come come questo trattato contenga tutta una serie di risvolti estremamente deleteri per la vita quotidiana delle popolazioni coinvolte, che viene negoziato in segreto tra Commissione UE e Governo USA basandosi sulle esigenze dei grandi gruppi transnazionali che, in larga misura confliggono con gli interessi non solo della “gente comune” ma anche delle fasce medio/basse delle imprenditorie nazionali (il che spiega determinate reazioni negative da parte di fasce medio/alte della società).
Il TTIP instaurerebbe due organismi tecnici estremamente invasivi. Il primo (Investor-State Dispute Settlement – ISDS) consentirebbe alle imprese di citare gli altrui governi nel caso in cui introducessero normative lesive dei loro interessi passati, presenti e futuri e, se ciò non bastasse, le vertenze verrebbero giudicate da un consesso riservato di avvocati commerciali specializzati, che devono giudicare solo in base alle regole TTIP senza fregarsene di qualunque altra considerazione, anche di carattere umanitario, ecologico, ecc., imprese e stati abbiano avuto in mente di salvaguardare. Detto per inciso, la procedura complessiva presenta costi complessivi altissimi, per cui basterebbe che una multinazionale o uno stato chiamassero in causa una piccola azienda per farle chiudere bottega.
Il secondo poi (il Regulatory Cooperation Council) sarebbe un organismo formato da esperti nominati della Commissione UE e del governo USA che avrebbe il potere di valutare l’impatto commerciale di qualsivoglia marchio, regola, etichetta, contratto di lavoro, standard di sicurezza, legislazioni operanti a qualunque livello: un organismo dove apparati governativi, imprese, sindacati, se discrezionalmente tirati in ballo, avrebbero un ruolo puramente consultivo. Il rapporto costi/benefici di ogni misura e il livello di conciliazione e uniformità tra USA e UE da raggiungere – quindi la loro effettiva introduzione o conservazione – sarebbe deciso da questo organismo, senza ulteriori livelli.
In pratica alimentazione, farmaci, energia, chimica, scuola, sanità, acqua, previdenza, pensioni, ecc. – per dirla in breve tutti i settori della produzione primaria, secondaria e terziaria – verrebbero esposti a feroci privatizzazioni ed alla acquisizione da parte delle imprese economiche e/o finanziarie maggiori, mentre attraverso procedure giudiziarie del genere prima esposto ogni genere di salvaguardia sociale, dai contratti di lavoro, alla previdenza, alla protezione ambientale, ecc. possono essere dichiarate illegali da un giorno all’altro.
In pratica, si tratterebbe della costituzione formale di un governo multinazionale delle multinazionali degno dei peggiori incubi complottistici sul “Nuovo Ordine Mondiale”, che andrebbe ad azzerare gradualmente diritti civili, politici e sindacali d’ogni sorta.
La storia di un simile progetto, però, non è nata dal nulla, anzi affonda le sue radici proprio nel periodo d’oro dello “stato sociale” a dimostrazione come le conquiste di questo periodo venissero assai malviste dai potenti della terra, subite come una necessità a causa dei rapporti di forza politico-sociali dell’epoca e con l’intento di farle fuori appena possibile. Infatti, già nel 1948 ventitré paesi avevano dato vita al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade): l’intenzione originale era quella di creare una terza istituzione da affiancare a quelle di Bretton Woods, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che si sarebbe dovuta chiamare ITO (International Trade Organization), con delle logiche non molto distanti da quello che sarà poi il WTO. I rapporti di forza dominanti tra le classi, come dicevamo, fecero restare fino al 1986 il GATT un accordo molto limitato, non tanto nel numero dei paesi paesi partecipanti che giunsero fino a centodue, quanto a livello contenutistico, limitandosi sostanzialmente ad un accordo tariffario.
Dal 1986 al 1994, non a caso in un periodo di graduale riflusso della forza contrattuale del movimento dei lavoratori, si svolse il cosiddetto “Uruguay Round”, che vide la partecipazione di centoventitré paesi e la messa in atto di una serie di accordi che andavano ben oltre il settore tariffario, andando a riguardare anche regole, servizi, proprietà intellettuali, regolazione delle dispute, settore tessile, agricoltura, ecc. e giungendo, nel nel 1995, alla creazione del WTO (World Trade Organization).
In larga parte, il WTO ha prefigurato, soprattutto nelle intenzioni (messe parzialmente fuori gioco dal movimento globale di opposizione che vide nelle giornate di Seattle il suo momento forse più alto, ma che è durato almeno fino alla metà del primo decennio del secondo millennio), le ipotesi operative dell’attuale TTIP, così come di molti accordi bilaterali minori. In effetti, il WTO oggi regola, con logiche ferocemente liberiste, agricoltura, servizi, movimento di persone, regolamenti sanitari e fitosanitari, trasporto aereo, tessile e abbigliamento, navigazione, standard dei prodotti, telecomunicazioni, investimenti, servizi finanziari, anti-dumping, metodi di valutazione, ispezioni navali pre-imbarco, regole sull’origine dei prodotti, licenze d’importazione, sussidi e strumenti di risposta a sussidi di altri paesi, misure protettive dalle importazioni in casi di emergenza, proprietà intellettuale, brevettabilità del vivente… in pratica tutto, con un ruolo destinato al settore pubblico del tutto residuale e con regolamentazioni “giudiziarie” che prefigurano quelle del TTIP.
In merito, vale la pena di ricordare la cosiddetta “disputa sulle banane”, il cui giudizio venne emesso dalla Giuria del Dispute Settlement Body istituita dal WTO. Premessa: l’Unione Europea aveva un regime privilegiato con le ex colonie di Africa, Caraibi e Pacifico, considerato un importante contributo economico alla stabilità politica ed alla crescita di questi paesi. L’11 aprile 1996, per conto della Chiquita Brands International, gli Stati Uniti si appellarono al WTO in base al principio WTO trade, not aid (commercio, non aiuto); il giudizio si risolse a favore degli USA con una sentenza che invitava l’UE a smantellare il regime di importazione delle banane da questi paesi. Nel gennaio 1998 la Commissione di Bruxelles presentò un ricorso che sosteneva che i paesi in questione non operano in condizioni di equa competizione in quanto la loro produzione deriva da piccole piantagioni imparagonabili ai latifondi latinoamericani controllati o direttamente posseduti dalle grosse società come Chiquita, Dole e Del Monte. La giuria del WTO, con una sentenza del 9 aprile 1999 ha dato definitamente ragione alla tesi americana, stabilendo in 191 milioni di dollari il risarcimento danni reclamabile dagli Stati Uniti, e l’Unione Europea ha dovuto attenersi alla decisione. Da notare che si trattava dell’Unione Europea, figuriamoci se a perdere una controversia, sia pure avendo dietro tutte le ragioni di questo mondo, fosse un piccolo stato od un privato.
Questo per dire che strutture del genere, al netto dei rapporti di forza, una volta istituite non restano senza effetti e la loro forza distruttiva ed erosiva di una minima moralità dei rapporti sociali si sviluppa con gradualità nel tempo. Ritornando alla cronologia che abbiamo esposto sopra, è interessante notare come accordi che vengono sbandierati come elementi di sviluppo e di creazione di ricchezza coincidano temporalmente, invece, con la creazione e l’approfondimento di crisi economiche.
Vale anche la pena di ricordare – le annate di Umanità Nova dal secondo dopoguerra ad oggi sono lì a testimoniarlo – come il movimento anarchico abbia sempre centrato l’obiettivo nella prefigurazione degli aspetti distruttivi per la vita quotidiana della maggioranza dell’umanità di simili accordi e nello sbugiardamento dei pretesi vantaggi collettivi di essi. Il libero commercio, da sempre, è stato solo il paravento ideologico per libere vessazioni dell’umanità: la “mano invisibile”, in realtà, è fatta di visibilissimi apparati legislativi, volti a rovinare ed umiliare la vita del 99% dell’umanità ed a concedere diritti vessatori incontrollati all’1%, per utilizzare le categorie del movimento Occupy Wall Street che, non a caso, è stato un esempio parzialmente vincente di opposizione alla crisi. Dallo Stato – tanto meno da un eventuale governo delle multinazionali – non possiamo aspettarci nulla, se non quello che ci danno e che non è per nulla il caso di accettare senza reagire.
Enrico Voccia
PRECAUZIONE, PREVENZIONE, SCIENZA, MORALE
Nel dibattito sul TTIP è uscita a margine la questione del cosiddetto “principio di prevenzione” e/o “precauzione”. In sé e per sé il principio di prevenzione (consistente nell’evitare/ridurre al minimo rischi già conosciuti e dimostrati come tali) ed il “principio di precauzione” (consistente nell’evitare rischi ipotetici o solo indiziari) non sono principi scientifici. Il primo, grosso modo, è un’applicazione di quella che Kant avrebbe chiamato una “regola della prudenza”: non porta a nuove conoscenze, ma è una semplice regola pratica terra terra del genere “prevenire è meglio che curare”. Il secondo, poi, da certi punti di vista, si appoggia su una variante della fallacia logica detta Argomentum ad ignorantiam, che si applica sostenendo che alcuni asserti sono necessariamente veri perché non vi sono prove in contrario: in effetti, il principio di precauzione non si fonda sulla disponibilità di dati che ci assicurano la presenza di un rischio – come nel principio di precauzione – ma sull’assenza di dati che assicurino il contrario. Da un punto di vista epistemologico, innanzitutto è difficile identificare con chiarezza la quantità di dati necessaria a dimostrare l’assenza di rischio, per cui la ricerca potrebbe non soddisfare mai lo scettico e, in questo caso, l’applicazione del principio di precauzione finirebbe per bloccare la ricerca scientifica su nuove tecnologie o prodotti, senza magari nemmeno preservare la salute dei cittadini e dell’ambiente.
L’argomento critico esposto contro il principio di precauzione, diciamolo subito, è valido: occorre, però, uscire dallo stretto ambito epistemologico e portare la questione in ambito politico/morale. Noi – purtroppo – viviamo in un mondo gerarchizzato e, all’interno di questo contesto, il principio di precauzione, preso cum grano salis, può risultare una difesa del debole contro il potente (ed è per questo motivo che viene attaccato all’interno di trattati come il TTIP, tutti volti a salvaguardare gli interessi dei potenti della terra).
L’alternativa ad una serie di dettagliati controlli preventivi obbligatori sulla non nocività di un prodotto, infatti, consiste nella pratica in vigore nella legislazione anglosassone: tagliando con l’accetta la questione, il prodotto viene immerso sul mercato senza o con minimi controlli e, se risulta nocivo, il cliente fa causa e, se la vince, riceve una soddisfazione giuridica in termini di condanne a pene pecuniarie e/o detentive del produttore. La questione, però, sta proprio nel passaggio giudiziario. Innanzitutto, il cliente è solitamente assai meno dotato di mezzi rispetto al produttore per affrontare i costi ed i tempi che possono essere notevoli di una causa, il cui esito non è per nulla certo a suo favore. Infatti, anche in presenza di danni accertati, data la poliesposizione di un organismo vivente ad una pluralità di sostanze ed ambienti nocivi, non è immediato ricondurre il danno subito a quello specifico prodotto. Il principio di precauzione, pertanto, tende a limitare le distanze gerarchiche: la sua espulsione dall’ambito politico-morale-giuridico tende ad espanderle.
lunedì, Febbraio 23, 2026